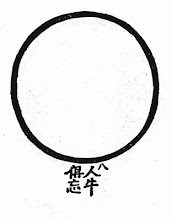DISCLAIMER: Non succede spesso che brandelli di storie diverse, come fette irregolari tagliate per pareggiare una sfoglia, si ritrovino per costruire qualcosa insieme. "Non succede spesso" è un'espressione che utilizzo impropriamente omettendo pudicamente un "a me" che fatico ad utilizzare, perché la proprietà, il riconoscere che un pensiero sia mio, è probabilmente il brandello più difficile da collocare, finendo inevitabilmente per essere tagliato a favore del mistero, dell'immaginazione e della poesia. Tuttavia, ricordando che il ribollire continuo della realtà ci presenta tanto spesso prove reali e prove immaginarie fino al punto da confonderle, non dobbiamo temere per la sorte di quegli avanzi, che sono tali soltanto in modo transitorio: di tutto non si butta via niente.

Era la prima domenica dopo la fine della guerra. Si era combattuto a lungo e malamente, su e giù per tutte le contrade. Le colline della regione, luoghi noti come stanze remote della casa allargata di ciascuno dei popolani, non si erano ancora del tutto liberate dei piccoli roghi e dei saccheggi perpetrati dalle compagnie di ventura in fuga. Chissà poi perché fuggissero: se perché non le avessero pagate abbastanza o perché non le avessero pagate affatto. La città dentro alle mura era cresciuta molto negli ultimi tempi, inglobando i reietti delle campagne in un clima di crescente promiscuità. Erano tempi felici, illuminati, di certo confusi.
Si alzavano le prime libecciate della stagione ed il soffiare pungente suggerì ai soldati di tramutare le trame delle casacche in fiamme, per riscaldare le membra spossate dei loro amanti. Doveva ancora essere inventata la minestra riscaldata, frutto di una sbandata del secolo successivo, per cui quel calore aveva uno scopo di cura e protezione dal candore tutto animale, tipo asino e bue.
Forse non vi ho mai raccontato due cose importanti per questo racconto.
La prima è che ho visto una cicala con i miei occhi per la prima volta quando avevo ventisette anni; prima, era soltanto un suono.
La seconda è che una sera, al tempo in cui credevo di essere diventato vecchio, incontrai in cima ad una salita un angelo in monopattino che mi rassicurò dicendo che ero ancora molto giovane.
La cosa bella di essere uno di quegli illusi che vedono dei segni anche dove non ce ne sono è che a volte i segni ci sono davvero, per lo stesso principio secondo cui anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Ed è l'ora giusta perfino al microsecondo, anzi al suo decimo e meno ancora. Insomma, la perfezione attraverso l'unica forma con cui questa si possa manifestare: il caso.
Vi racconto queste due cose perché sono collegate tra loro e, pertanto, sono collegate anche a tutto il resto.
Era davvero un grande libeccio, profumato dall'odore di grigliata e chiodi di garofano, ed il re non riusciva a dormire. Non era mai stato re in tempo di pace e la cosa lo preoccupava molto. Si vedeva già detronizzato, alla gogna, cancellato dai libri di storia. Uscì a fare due passi, camuffato da viandante, cercando conforto nel vernacolo del popolino. Gli ubriachi lo scontravano, gli stupidi cercavano di attaccare briga ed i più chiassosi cercavano in tutti i modi di fregare lui e gli altri che, come lui, andavano per le vie illuminate a festa cercando semplicemente di farsi i fatti propri.
Il re era ancora turbato, ma si disse che quello era il suo popolo e che soltanto così avrebbe trovato conforto. Altrimenti ci avrebbero pensato la gogna, il patibolo e compagnia cantante. Qualcuno si avvicinò per offrirgli una tazza di vino caldo: bevve avidamente e fu come se gli gettassero una mano calda nel petto. Ancoratasi alla sua gabbia toracica, gli diede una carezza tale al cuore da portarlo a pensare alla sua stanza nelle viscere del castello, alle sue pelli d'orso ed all'inverno che sarebbe infine giunto con le sue bufere di neve a liberare le strade da quei bifolchi. Quanto erano belle, specialmente spolverate di bianchi fiocchi, le strade della sua città! Ma quel qualcuno che gli aveva teso la tazza volle anche due soldi in cambio del vino e la piacevole sensazione svanì in tutta fretta.
Proprio mentre pagava, si accorse di un ragazzo nella folla che lo guardava con insistenza. Che voleva? Si avvicinò, benché il re avesse cercato invano di ripararsi tra i ventagli di sette donzelle che passavano da lì, turbinando tra le viuzze in salita. Nonostante il suo travestimento, il ragazzo doveva averlo riconosciuto.
Avevano combattuto insieme alla Piana dell'Avvelenata. "Combattere" era un'esagerazione: si erano trattenuti per tre giorni in quel posto arido e buio, lucidando le punte delle picche, in attesa di un nemico che non sarebbe mai arrivato, sconfitto in anticipo da qualche cugino arrivista del re.
Solo una volta quest'ultimo era uscito dalla sua tenda, per prendere giusto una boccata d'aria, e proprio in quell'occasione aveva incrociato lo sguardo con un soldatino, un fante con gli occhi sconvolti ed abbandonati alla provvidenza.
Se ne ricordava anche il re, di quell'incontro: impossibile negare.
Il giovane spiegò di aver visto una tetra figura inseguirlo per tutta la città, fino in cima alle mura.
Sbirciando dai caditoi, il ragazzo aveva riconosciuto nella sagoma vestita di nero una signora che...e qui il re lo interruppe: che si trattasse del suo senso di colpa personificato, di una fanciulla che aveva amato e poi scaricato una volta passata la paura della battaglia, fosse anche stata la morte in persona a lui non fregava niente e non erano affari suoi.
Girò i tacchi, dirigendosi verso una baracca che serviva sidro e frittelle.
Il giovane lo inseguì, sbraitando. Era ubriaco, più di quanto sembrasse. Si avvinghiò al re trascinandolo nel fango mente un tuono spalancava una cascata d'acqua sulla città. Accapigliandosi, i due caddero da un parapetto, demolendo la tenda del venditore di cucchiai, che si era allontanato cercando l'amore sotto al temporale.
Un fulmine illuminò brevemente l'esito della colluttazione: la festa era stata interrotta dalla pioggia e la vita del re da un cucchiaio nel cuore.
Sic transit gloria mundi.
Chissà cosa ne avrebbero detto i cronisti, se qualcuno avesse capito che quel viandante sfortunato era proprio lui. I posteri avrebbero saputo solo che era sparito, alla fine della guerra, come un essere benevolo che avesse finito il suo compito: un santo. Frugando nelle sue vesti, il soldato trovò un anello col simbolo reale e mostrandolo agli stallieri li convinse quindi a farsi dare il cavallo più veloce del regno, come se fosse un ordine sovrano, lasciando in tutta fretta quel temporale, quella città, quel cadavere e quella nera signora dietro di sé.
Qui la storia dovrebbe finire, e invece continua.
La nera signora incontrò un biondo cavalleggero, un bravo ragazzo di buona famiglia, che si offrì di riaccompagnarla a casa. Vissero felici, in campagna, amministrando le ricche proprietà delle rispettive famiglie. Quale che fosse il suo ruolo, quella notte, la nera signora lo perse per acquisire quest'altro. Con la fine dell'aristocrazia, lei ed il suo compare vennero messi sul rogo come il resto della nobiltà dal popolo che, incerto sul trattamento da riservare alle persone del loro lignaggio, gli diede il posto più in alto sulla pira, per garantirgli la vista migliore.
Il regno fu preso per mano da un cugino del re, un tale che si innamorò delle sue montagne. Le idolatrava, senza parlare d'altro. Finì per essere un buon re soltanto perché l'interesse del popolo coincideva con quello delle sue amate catene montuose.
Del giovane soldato sappiamo poco o nulla. Una sera d'estate fermò il cavallo ad un bivio dove due volpi giocavano a rincorrersi. Una voce, da dentro una grotta, gli chiese di raggiungere la cima di una torre. Superati torrenti impetuosi e profondi crepacci, arrivò finalmente ad una torre, una qualsiasi.
La porta era aperta ed egli entrò, senza capire bene cosa significasse. Raggiunta la cima, la sensazione di non capire si fece sempre più forte e sempre più pressante. Perché era salito? Perché non succedeva niente? Scese e trovando il cavallo che lo fissava con il muso nella biada capì di non essere il protagonista di quella storia, proprio come quel cavallo così veloce non era stato che uno dei personaggi della sua. Quella torre era la scena di uno spettacolo che non gli apparteneva ed il giovane ne fu amareggiato: dove era la sua storia? Quando era finita?
Una fresca brezza gli anticipò la sensazione di fine dell'estate, come se l'autunno fosse ormai imminente. Era più di un presagio: il tempo sembrava come aver fatto un balzo in avanti, negando alla stagione più calda ciò che le spettava ancora da trascorrere.
Il cavallo nitrì ed a quel punto il soldato notò una cicala sulla sella. Non emetteva alcun suono, eppure era lì: nonostante tutto, era ancora estate.
Anche adesso la storia dovrebbe finire e, invece, continua ancora.
La cicala ritornò nella sua tana, evitando la strada maestra per non incontrare nessuno. Aveva perduto la voce, ma in cambio aveva imparato a scrivere. In ogni caso, la cosa la faceva molto vergognare. A cosa poteva servire, una cicala incapace di cantare? Ripensò al suo amore: una bella cicala che ogni tanto passava nel suo cuore perché, diceva, quello era il luogo più caldo del mondo.
Sorrise: non era nemmeno sicura che le cicale avessero un cuore, tantomeno che potessero sorridere. Ma adesso che sapeva scrivere capiva che quella era soltanto una parafrasi, un modo di dire una cosa semplice con troppe parole: si amavano. Le scrisse una poesia e fece scendere quel foglio spiegazzato giù, fino in fondo al suo carapace, là dove credeva di trovarla.
Quando poi sei arrivatain mezzo a tutti i problemi che mi ero fattoe hai detto: "certe cose ci stanno bene
certe altre non ci stanno affatto"se non sei ancora fuggitasarà perché siamo compressistretti in un'unica vitacome cimiteri e cipressi.
Che cosa fosse un cipresso o un cimitero non poteva saperlo, eppure la poesia recitava così. Erano solo parole che stavano bene insieme, senza significato, con la stessa naturalezza di due persone che sanno che esiste la morte, ma non gli importa.
E qui la storia finisce, perché parlare d'amore è un po' come contare i cerchi degli alberi per capire quante stagioni abbiano vissuto: si parte dal centro, ed ogni volta che perdi il conto ricominci da capo.