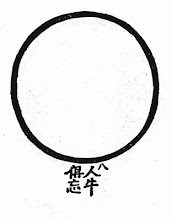mercoledì, ottobre 30, 2019
Prussian Blues
Era in corso, ormai da qualche ora, il temporale più lungo e forte dell'anno.
I torrenti si stavano ingolfando rapidamente, avvicinando le loro acque sudice agli argini come mani di affamati al pane.
Curzio accese un'altra sigaretta. Da quando lui lo aveva lasciato aveva ripreso a fumare, ma non riusciva a pentirsene abbastanza per smettere.
- Curzio, andiamo: smettila di fumare.
- Dai Petroni, sono un adulto: fumo quanto cazzo mi pare, giusto?
Petroni si avvicinò alla scrivania di Curzio. Era un uomo alto, con la faccia rossa e asciutta come un mattone. Uno che non sapeva scherzare. Ci provava, ma il più delle volte non ci riusciva. Aveva un bambino piccolo simpaticissimo, che doveva aver preso dalla madre. Alle volte era palese che ne soffrisse. Non di non saper scherzare, ma che il figlio avesse preso dalla madre.
- Curzio: stiamo andando. Devi smetterla di fumare perché in macchina con la sigaretta non ci sali.
Finirono entrambi con le scarpe dentro la gigantesca pozzanghera che separava il palazzo dal parcheggio.
- Dove dobbiamo andare, con questo tempo? C'è l'allerta.
Petroni innestò la prima.
- Sai, una volta avevo una ragazza come te. Insomma: tu me la ricordi molto.
Doveva essere un basso naturale, o qualcosa del genere: ogni tanto le scrosciate di pioggia sulla carrozzeria e sul parabrezza si sovrapponevano alle sue parole, tanto erano simili le loro tonalità.
- Faceva sempre domande. Parlava per domande. L'unica volta che non finì una frase con un punto interrogativo fu per dirmi che mi lasciava.
- Cioè, fu lei a lasciarti?
- Lo vedi? Anche tu parli per domande. E' una cosa su cui dovresti riflettere, Curzio.
La pioggia non accennava a smettere. Un fuoristrada della protezione civile li avvicinò in galleria per capire come mai fossero in giro a quell'ora, con quel tempo. Magari, chiese il tizio della protezione civile, avevano bisogno di aiuto. Fu Curzio a parlare. Con collaudate frasi fatte fu abbastanza convincente da farli desistere e sufficientemente evasivo da non dare loro troppe informazioni.
Arrivarono all'incrocio mentre il palazzo veniva illuminato dall'incessante, epilettico bagliore giallastro di quella tempesta di fulmini di fine estate. Sembrava che da un momento all'altro la trama del cielo dovesse squarciarsi per rivelare milioni di asteroidi infuocati pronti ad incenerire il pianeta. Petroni aprì il bagagliaio per prendere la sacca e si accorse che qualcosa stava tentando, invano, di distrarlo. Era un ricordo di molti anni prima: l'acqua scrosciante sui bordi della tenda, la faccia sferzata dal vento freddo mentre, insieme ai suoi fratelli, guardava un temporale proprio come quello scuotere gli alberi al bordo della radura in cui si erano accampati. Il sapore della camomilla e il calore del corpo avvolto nella mite umidità del sacco a pelo, come in una placenta artificiale, si erano mischiati - allora e ancora nel ricordo stesso - fino a diventare una percezione unica, multisensoriale, che a sua volta richiamava un periodo epico, al tempo della sua stessa gestazione.
Salirono le scale antincendio in silenzio, usando grande circospezione. L'acqua, mal tollerando la loro presenza, scorreva giù dalla facciata come una cascata, costringendoli ad una doccia continua. Le calze di Curzio, ormai totalmente bagnate, lo mettevano a disagio. Non vedeva l'ora di togliersi di dosso la sensazione avere i piedi umidi e grinzosi.
Arrivarono al tetto.
Petroni depositò la sacca a terra e prese una torcia per esaminare un foglio che aveva precedentemente plastificato. Con tutte quelle saette, la torcia praticamente non serviva.
Curzio estrasse le macchine fotografiche dalla sacca. I tappi degli obiettivi, prodotti in qualche angolo remoto del mondo dove probabilmente, in quello stesso momento, stava splendendo un grande sole rosso rubino, vennero subito imperlati da miliardi di minuscole gocce d'acqua.
- E se adesso mi colpisse un fulmine?
La domanda non era rivolta a nessuno. Petroni lo capì e si limitò a sospirare.
Riprese ad esaminare il foglio, leggendo con le labbra.
Curzio impugnò la macchina fotografica, aggiustò il parapioggia, prese la mira e cliccò. Lo scatto, cadendo precisamente tra un tuono e l'altro, venne archiviato dal temporale come cosa di poco conto.
- Ok, qui dice che basta così. Andiamo.
- Tutto qui?
- Curzio, ti prego: basta domande.
Ritornarono lentamente alla macchina. Curzio salì dalla parte del guidatore e si tolse le scarpe mentre Petroni rimetteva la sacca nel bagagliaio.
- Che cosa fai? Guidi scalzo?
Curzio non rispose e la macchina si avviò lentamente per tornare da dove era venuta.
Giorni dopo si fermarono al semaforo di quello stesso incrocio. Splendeva il sole ed i piccioni si rincorrevano sul marciapiede per contendersi la briciola più grande di tutti. Petroni aveva gli occhiali da sole e dalla sua posizione sul sedile del passeggero si sarebbe detto che dormisse.
Qualcosa bussò alla porta dell'attenzione di Curzio, trovandola socchiusa: era un ricordo, anzi, una collana di ricordi. Una lunga catena di frammenti che si erano riconosciuti simili tra loro ed ora chiedevano di essere esaminati. Il Petty Pigment si affacciava proprio su quell'incrocio: era un locale dove non era mai stato, ma lui gliene aveva parlato. Benché non ricordasse precisamente le parole del racconto, riusciva distintamente a ricordare l'immagine che si era fatto di quella serata.
Lui, con una maglietta attillata e fresco di doccia, entrava nel locale fumoso dove un terzetto blues rimaneggiava con mani inesperte i grandi standard del genere. Si sedeva al bancone aspettando qualcuno. Il suo lento respiro dopo l'allenamento intervallato da lunghissime sorsate di birra fresca. Aveva gli occhi arrossati dal fumo e dal neon. Finalmente il tizio, un compagno del liceo magrolino e con la faccia gialla come un limone, gli picchiettava sulla spalla per annunciare il suo arrivo. Baci e abbracci. Si spostavano ad un tavolo più appartato mentre Mannish Boy veniva stuprata sul palco. Lui, durante lo spostamento, veniva inquadrato solo di schiena. Quella gigantesca schiena pelosa, fasciata dalla tela acida della maglietta, invadeva tutto lo schermo.
Altra birra ed occhi sempre più arrossati, convenevoli e qualche battuta.
Ad un certo punto, proprio mentre la band lasciava il palco per far spazio a musica registrata e suonata meglio, l'amico riceveva una telefonata.
Una cosa da niente, che tuttavia gli aveva dato il tempo di vagare con il pensiero, soffermandosi sul discorso del tavolo a fianco. Per via del divano che condividevano e li separava, non poteva vedere la ragazza che stava parlando: solo sentirla. Sembrava che la musica fosse stata cambiata ed abbassata di proposito.
La tizia si esprimeva per domande: aveva un fidanzato fotografo? Che insisteva per portarla a pescare ogni weekend? Mentre lei sarebbe voluta restarsene a casa per guardare E.R, giusto?
Tutti questi dettagli, che lui al tempo gli aveva raccontato solo come pretesto per imitare il buffo accento e l'oratoria interrogativa di quella sconosciuta - per riderne insomma - componevano finalmente un quadro chiarissimo. Petroni era il fidanzato con la fissa della pesca, che presto sarebbe stato lasciato. Di quanti anni prima poteva trattarsi?
Guardò Petroni riflesso contro le plastiche argentate del cruscotto, mentre il semaforo diventava verde per portarli lontano dal Petty Pigment. Avrebbe voluto saperne di più di quella ragazza, del perché il destino o chi per lui avesse così chiaramente deciso di mettere in contatto il suo passato con il suo presente proprio attraverso di lei.
- Cosa fa oggi?
- Dio mio Curzio: non solo mi fai sempre domande, adesso ti perdi perfino i soggetti. Di chi stai parlando?
Si schiarì la voce. Da dove cominciare? Dritto al sodo, improvvisamente.
- La tua ex. Cosa fa oggi?
Anche Petroni si schiarì la voce, come se fosse stato preso in castagna. Forse ci stava ripensando anche lui.
- Ha lasciato la città. Vive in una comune che nega il valore del lavoro. Non so altro.
Aveva finito le domande: avrebbe voluto farne ancora, ma il tono della voce di Petroni non ne ammetteva altre. Dovette ricorrere ad uno stratagemma.
- E il suo nome era...
- ...Violet, si chiamava così.
Curzio ripeté il nome più volte nella sua mente, cercando di assimilarlo.
Violet, ma certo: il viola viene sempre dopo il blues.
venerdì, ottobre 11, 2019
Glory whole
Eravamo ormai delle vecchie baldracche.
Come fossimo diventate baldracche lo sapevamo: qualcosa, al termine della nostra pubertà, era scattato in modo repentino e attento, come qualcuno che apre una porta cigolante di botto, sapendo che così farà meno rumore.
Come fossimo diventate vecchie restava ancora un mistero.
Le cose si erano sicuramente complicate negli interminabili viaggi. Il sonno rubato a spizzichi e bocconi tra un terminal e l'altro, sballottate solo con un po' più di grazia delle nostre valige, su e giù per la grande giostra volante. Il sole sorgeva e se ne andava semplicemente quando ce n'era bisogno, senza essere più collegato ad un orario o a un quadrante. Qualche furbacchione cercava sempre di riportare le cose ad un riferimento certo, con scarso risultato. Il caro vecchio meridiano di Greenwich poteva anche andare a farsi fottere.
Ecco, l'altra cosa furono le parolacce. Fino alle soglie dell'età adulta, prima che tutto cominciasse a ripetersi ritornandoci in gola come un minestrone acido e mai davvero digerito, l'uso delle parolacce era sempre stato misurato e attento. Esse si stagliavano nel percorso dell'innocenza come epiche pietre miliari, fari che permettevano di misurare le distanze e quindi il tempo. Quella volta che la suora era scivolata e lo aveva detto, quella volta che tirammo un petardo tra le gambe di un passante e disse la stessa sei volte di fila, quella volta che l'allenatore ci prese da parte per dirci tutte quelle che aveva dovuto trattenere durante la partita. Da un certo punto in avanti però, era tutto diventato un cazzo, stronzo, fica, bucodiculo, puttana, merda, troia e poi ancora cazzo e cazzo e cazzo, all'infinito.
Forse avevamo fatto male, da giovani, a prendere questi elementi come metri per il passare del tempo, ma cosa potevamo saperne?
Mi accorgo del passare delle stagioni attraverso i piedi. Per questo motivo, a causa delle calze, l'inverno mi sembra interminabilmente lungo. Quando vedo uno schermo altrui ho subito lo stimolo di guardare, sbirciando: capire senza dover sapere. O viceversa, comunque è il vizio di una vita intera.
Ascoltando Dvorak aveva sempre l'impressione che il mondo dovesse finire da un momento all'altro.
In effetti, ascoltava sempre e soltanto la nona sinfonia: "Dal Nuovo Mondo".
Era rimasto estasiato nell'apprendere la nozione, innestata per sempre nella sua memoria anni prima durante la lettura di un qualche numero primo della Settimana Enigmistica, attraverso quel meccanismo perfetto e arcano del "Forse Non Tutti Sanno Che...", che Neil Armstrong portasse con sé proprio quell'opera durante la missione Apollo 11. Benché ascoltasse anche altro, di altri musicisti e di Dvorak stesso, nulla pareva emozionarlo e coinvolgerlo allo stesso modo.
Ascoltando Dvorak aveva sempre l'impressione che il mondo nuovo non fosse semplicemente una manifestazione rinnovata di questo ma proprio un Nuovo Mondo che, sconquassando e distruggendo, irrompesse in una bella giornata di sole per cancellare tutto ed imporre su ogni cosa la propria identità. Un giorno mi disse che facendo attenzione si potevano perfino sentire le colonne del mondo sgretolarsi sotto l'impeto di quel tetro avvicendamento.
A me sembrava solo il suono dello strisciare della puntina sul disco, ma per lui non faceva differenza. Cercavo invano di distrarlo con ogni mezzo: puntualmente, proponevo un nuovo ascolto delle danze slave per dare una prospettiva più rosea, o almeno meno statica, alla sua visione. Inutile. Perfino le teorie complottiste, un classico delle menti geniali tenute troppo a digiuno, non riuscivano a scalfire quel presagio mistico che lo richiamava a sé, ascolto dopo ascolto. Forse non tutti sanno che un certo August Dvorak, lontano parente del celebre compositore che aveva combattuto contro Pancho Villa, viene tutt'oggi ricordato per aver creato una tastiera speciale che...non importa.
Anni dopo, ormai distanti nel tempo e nello spazio, ebbi come un'illuminazione: la gloria era ciò che lo aveva fulminato. La gloria, tutta intera, tutta in una botta unica, lo aveva circondato e annientato.
Gloria, sostantivo femminile: onore universalmente riconosciuto e tributato nei confronti di un valore assolutamente eccezionale.
La nona sinfonia per lui era la quintessenza della gloria o, meglio, la gloria gloriosa. Il trionfo del trionfo, l'orgasmo al quadrato. Non aveva altro modo per spiegarsi questo cortocircuito sensoriale se non descrivendolo come la fine del mondo.
In un certo senso, il mondo era davvero finito. Tra le porche troie e tutte le altre parolacce sibilate contro un destino molto più ignoto che crudele, il tempo era passato ed il mondo nuovo si era sostituito al vecchio. Si potrebbe dire che era stata una rivoluzione pacifica, quasi desiderata. Come una porta cigolante aperta di scatto per fare meno rumore.
Ogni tanto provavo ancora a riascoltare l'attacco delle danze slave per vedere se riuscivano a farmi rivivere quella sensazione. L'euforia di essere euforici, l'eccitazione dell'eccitamento, la gloria tutta intera. Niente, dovevo averla consumata, proprio come avevo consumato la sorgente di nostalgia che zampillava dalla suite per violoncello di Bach. Avevo come un lontano ricordo di aver già consumato e ricaricato quella sensazione altre volte, ma non riuscivo più a mettere in ordine gli eventi ed il senso con cui si erano svolti. Forse ero ancora un feto la prima volta che la musica aveva perso la possibilità di trasmettermi quella sensazione per la prima volta. Magari iniziavo a strutturare dei ricordi giusto nel momento in cui la vena si era esaurita di nuovo e via così, all'infinito, distillando la sensazione della ricerca della sensazione.
Doveva necessariamente esserci un modo per leggere quelle maree, una rappresentazione cartografica dei modi di vibrare dell'animo quando viene sollecitato da un'aria sulla terza corda. Deve esistere. La rappresentazione cubista delle frequenze che descrivono l'anima attraverso le sensazioni che essa stessa prova, esprime ed è.
Come fossimo diventate baldracche lo sapevamo: qualcosa, al termine della nostra pubertà, era scattato in modo repentino e attento, come qualcuno che apre una porta cigolante di botto, sapendo che così farà meno rumore.
Come fossimo diventate vecchie restava ancora un mistero.
Le cose si erano sicuramente complicate negli interminabili viaggi. Il sonno rubato a spizzichi e bocconi tra un terminal e l'altro, sballottate solo con un po' più di grazia delle nostre valige, su e giù per la grande giostra volante. Il sole sorgeva e se ne andava semplicemente quando ce n'era bisogno, senza essere più collegato ad un orario o a un quadrante. Qualche furbacchione cercava sempre di riportare le cose ad un riferimento certo, con scarso risultato. Il caro vecchio meridiano di Greenwich poteva anche andare a farsi fottere.
Ecco, l'altra cosa furono le parolacce. Fino alle soglie dell'età adulta, prima che tutto cominciasse a ripetersi ritornandoci in gola come un minestrone acido e mai davvero digerito, l'uso delle parolacce era sempre stato misurato e attento. Esse si stagliavano nel percorso dell'innocenza come epiche pietre miliari, fari che permettevano di misurare le distanze e quindi il tempo. Quella volta che la suora era scivolata e lo aveva detto, quella volta che tirammo un petardo tra le gambe di un passante e disse la stessa sei volte di fila, quella volta che l'allenatore ci prese da parte per dirci tutte quelle che aveva dovuto trattenere durante la partita. Da un certo punto in avanti però, era tutto diventato un cazzo, stronzo, fica, bucodiculo, puttana, merda, troia e poi ancora cazzo e cazzo e cazzo, all'infinito.
Forse avevamo fatto male, da giovani, a prendere questi elementi come metri per il passare del tempo, ma cosa potevamo saperne?
Mi accorgo del passare delle stagioni attraverso i piedi. Per questo motivo, a causa delle calze, l'inverno mi sembra interminabilmente lungo. Quando vedo uno schermo altrui ho subito lo stimolo di guardare, sbirciando: capire senza dover sapere. O viceversa, comunque è il vizio di una vita intera.
Ascoltando Dvorak aveva sempre l'impressione che il mondo dovesse finire da un momento all'altro.
In effetti, ascoltava sempre e soltanto la nona sinfonia: "Dal Nuovo Mondo".
Era rimasto estasiato nell'apprendere la nozione, innestata per sempre nella sua memoria anni prima durante la lettura di un qualche numero primo della Settimana Enigmistica, attraverso quel meccanismo perfetto e arcano del "Forse Non Tutti Sanno Che...", che Neil Armstrong portasse con sé proprio quell'opera durante la missione Apollo 11. Benché ascoltasse anche altro, di altri musicisti e di Dvorak stesso, nulla pareva emozionarlo e coinvolgerlo allo stesso modo.
Ascoltando Dvorak aveva sempre l'impressione che il mondo nuovo non fosse semplicemente una manifestazione rinnovata di questo ma proprio un Nuovo Mondo che, sconquassando e distruggendo, irrompesse in una bella giornata di sole per cancellare tutto ed imporre su ogni cosa la propria identità. Un giorno mi disse che facendo attenzione si potevano perfino sentire le colonne del mondo sgretolarsi sotto l'impeto di quel tetro avvicendamento.
A me sembrava solo il suono dello strisciare della puntina sul disco, ma per lui non faceva differenza. Cercavo invano di distrarlo con ogni mezzo: puntualmente, proponevo un nuovo ascolto delle danze slave per dare una prospettiva più rosea, o almeno meno statica, alla sua visione. Inutile. Perfino le teorie complottiste, un classico delle menti geniali tenute troppo a digiuno, non riuscivano a scalfire quel presagio mistico che lo richiamava a sé, ascolto dopo ascolto. Forse non tutti sanno che un certo August Dvorak, lontano parente del celebre compositore che aveva combattuto contro Pancho Villa, viene tutt'oggi ricordato per aver creato una tastiera speciale che...non importa.
Anni dopo, ormai distanti nel tempo e nello spazio, ebbi come un'illuminazione: la gloria era ciò che lo aveva fulminato. La gloria, tutta intera, tutta in una botta unica, lo aveva circondato e annientato.
Gloria, sostantivo femminile: onore universalmente riconosciuto e tributato nei confronti di un valore assolutamente eccezionale.
La nona sinfonia per lui era la quintessenza della gloria o, meglio, la gloria gloriosa. Il trionfo del trionfo, l'orgasmo al quadrato. Non aveva altro modo per spiegarsi questo cortocircuito sensoriale se non descrivendolo come la fine del mondo.
In un certo senso, il mondo era davvero finito. Tra le porche troie e tutte le altre parolacce sibilate contro un destino molto più ignoto che crudele, il tempo era passato ed il mondo nuovo si era sostituito al vecchio. Si potrebbe dire che era stata una rivoluzione pacifica, quasi desiderata. Come una porta cigolante aperta di scatto per fare meno rumore.
Ogni tanto provavo ancora a riascoltare l'attacco delle danze slave per vedere se riuscivano a farmi rivivere quella sensazione. L'euforia di essere euforici, l'eccitazione dell'eccitamento, la gloria tutta intera. Niente, dovevo averla consumata, proprio come avevo consumato la sorgente di nostalgia che zampillava dalla suite per violoncello di Bach. Avevo come un lontano ricordo di aver già consumato e ricaricato quella sensazione altre volte, ma non riuscivo più a mettere in ordine gli eventi ed il senso con cui si erano svolti. Forse ero ancora un feto la prima volta che la musica aveva perso la possibilità di trasmettermi quella sensazione per la prima volta. Magari iniziavo a strutturare dei ricordi giusto nel momento in cui la vena si era esaurita di nuovo e via così, all'infinito, distillando la sensazione della ricerca della sensazione.
Doveva necessariamente esserci un modo per leggere quelle maree, una rappresentazione cartografica dei modi di vibrare dell'animo quando viene sollecitato da un'aria sulla terza corda. Deve esistere. La rappresentazione cubista delle frequenze che descrivono l'anima attraverso le sensazioni che essa stessa prova, esprime ed è.
Iscriviti a:
Post (Atom)